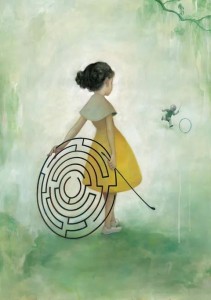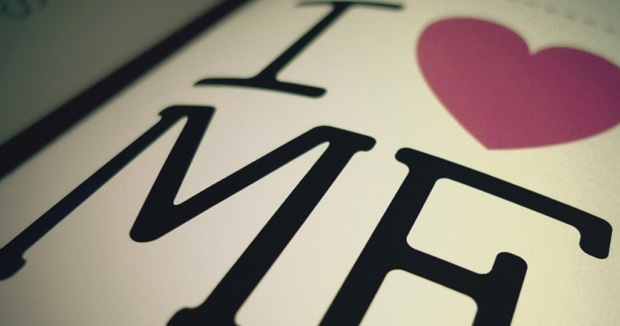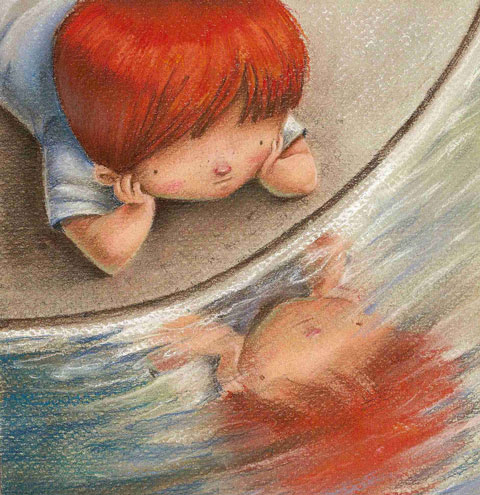(Questo articolo è disponibile nella sua versione in lingua originale al link: http://deafness.about.com/od/families/a/growupcoda.htm )
Com’è crescere da bambino udente, figlio di genitori sordi, un CODA? Jake, un adulto udente che è cresciuto con genitori sordi, adesso morti, ha condiviso la sua esperienza con About.com. Leggi la storia di Jake, che ha avuto luogo decenni fa. Cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale per i bambini che crescono CODA oggi?
D: In che periodo sei cresciuto?
R: Sono nato nel 1956, quindi la mia infanzia si è svolta principalmente negli anni ’60.
D: Come hai imparato a parlare? (Come fa un bambino udente con genitori che non parlano, ad imparare a parlare?)
R: io ero il primogenito, e non c’erano altre persone udenti che si fermassero regolarmente, così ho imparato a parlare quando ero già abbastanza grande da andare fuori a giocare con gli altri bambini udenti, all’età di circa 4 o 5 anni.
D: Eri mai imbarazzato dal fatto che i tuoi genitori fossero sordi?
R: Ricordo quando volevo segnare ai miei genitori in macchina e loro mi dicevano di tenere le mani un po’ più giù. Io penso che questo abbia contribuito a rendermi piuttosto imbarazzato nell’attirare un qualche tipo di attenzione segnando in pubblico. Comunque, non avrei mai parlato liberamente e avrei aspettato di dire o chiedere qualcosa ai miei genitori finché non ci fossimo trovati in una zona privata, specialmente quando dovevo fare da interprete per loro con i commercianti o altre persone d’affari.
D: Come gestivano i tuoi genitori gli incontri genitori-insegnanti a scuola?
R: Non sono mai andati. Potrebbe essere perché gli anni ’60 non erano l’epoca degli interpreti. Non furono mai nemmeno convocati a scuola per qualche problema di comportamento. Lo stesso valeva anche per andare in chiesa. Comunque, ricordo di una volta in cui mia madre venne a scuola, durante la mia prima elementare, e successivamente scoprii che le era stato detto che avevo bisogno di ripetere la prima classe.
D: Come socializzava la tua famiglia?
R: Crescendo, i miei genitori portavano noi bambini ai parchi divertimento, in estate una settimana di vacanze in spiaggia in New Jersey e a visitare i loro amici sordi il sabato sera o la domenica, e molti di loro avevano bambini vicini alla mia età. Invitavano anche i loro amici sordi a venirci a trovare nella nostra casa il fine settimana.
D: Hai avuto qualche fratello udente o sordo?
R: C’erano solo due bambini nella nostra famiglia, ed entrambi erano udenti. Sembra che mio padre fosse diventato sordo accidentalmente mentre era ancora nell’utero o subito dopo la nascita, mentre per mia madre è accaduto quando era bambina. Inoltre, nessun familiare da entrambi i lati dei miei genitori era sordo o con problemi di udito.
D: Come interagivano i tuoi genitori con i genitori udenti dei tuoi amici?
R: I miei genitori socializzavano principalmente con i loro amici sordi. Comunque, nel nostro quartiere di 20 file di case (Philadelphia, Pa.) c’erano, inclusi i miei genitori, quattro persone sorde! I miei genitori avrebbero voluto socializzare anche con questi altri due. Così come gli adulti del vicinato, i miei genitori, specialmente mia madre, avrebbero parlato, ma non è mai stato per visite prolungate tranne che per poche eccezioni.
D: I tuoi genitori erano attivamente coinvolti nella comunità sorda? Se si, ti portavano agli eventi per sordi e alle assemblee?
R: Sì, mia madre ci portava a varie attività per sordi nell’area di Philadelphia (dove è cresciuta), come alle attività nelle chiese, al bingo, serate film, picnic alla PA School for the Deaf e alla prima casa per Sordi e Ciechi, ecc. Mio padre era del New Jersey, così tutti e quattro andavamo ai club per sordi e partecipavamo alle attività del New Jersey.
D: C’è altro che vuoi aggiungere sulla tua esperienza di crescita come CODA?
R: Sì,le domande sopra hanno toccato della aree che vorrei sviluppare:
• Non ho frequentato l’asilo, la scuola materna o la primina, cosa che sono sicuro ha ritardato la mia acquisizione del linguaggio come bambino udente e ha probabilmente causato, sia per me che per mia sorella, il dover ripetere gli anni a scuola.
• Negli anni ’50 non c’erano test che potessero diagnosticare se un bambino fosse udente o sordo al momento della nascita, quindi i miei genitori erano molto ansiosi di scoprire se io fossi udente o no. Sono sicuro che loro avrebbero amato un bambino sordo, se ne avessero avuto uno, ma hanno preferito avere un bambino udente.
• Anche se i miei genitori hanno provveduto ai bisogni di base, a nutrirci, a proteggerci e a vestirci bene, per noi due bambini, non sono stati in grado di renderci sicuri di noi stessi. Io penso che fosse perché sentivano che se una persona era udente era adeguatamente preparata ad affrontare la vita. Come risultato, io ancora combatto con problemi di autostima. Adesso all’età di 51 anni, faccio ancora lavori sotto-pagati, non ho mai avuto una relazione a lungo termine, ecc.
• Penso che i bambini udenti nati da genitori sordi crescano sentendosi parte di entrambi i mondi, quello dei sordi e quello degli udenti, ma molti sordi, specialmente quelli che ho incontrato per la prima volta da adulto, sembrano metterci interamente in una categoria, quella degli udenti e in qualche modo mi ignorano. (Posso capire che loro possano essersi sentiti nello stesso modo andando nelle scuole per sordi con praticamente tutto il personale udente ecc . e con la famiglia che non si preoccupava di imparare la Lingua dei Segni o che li escludeva dai discorsi di famiglia.)
(Traduzione a cura della Dott.ssa Romina Rubino)
Segui su Facebook la pagina dei CODA Italia (Children of Deaf Adults), un’Associazione di Promozione sociale nata in Italia che si occupa di figli udenti di genitori sordi.